UNA VISIONE OLISTICA DEL RAPPORTO MEDICO-PAZIENTE E PAZIENTE-MEDICO
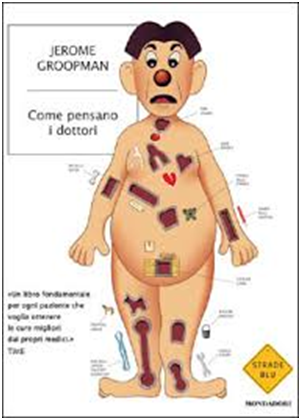
Da una sana lettura alcune considerazioni sulle esperienze dell’attività medica di clinici operanti all’estero, soprattutto negli Stati Uniti
di Ernesto Bodini (giornalista scientifico e biografo)
Da tempo, ormai, non si fa altro che parlare di medici in merito ai loro diversi problemi che ben tutti conosciamo. Ma io credo che la maggior parte delle persone non entri (o non osi entrare) nel merito della loro personalità che, va detto, implica alcune caratteristiche come la loro preparazione, i loro timori, le loro incertezze e soprattutto il loro modo di porsi nei confronti dei pazienti. Una convinzione lontana nel tempo, si direbbe, ma in realtà in alcuni casi potrebbe avere ancora la sua valenza, pur considerando che le procedure e la tecnologia specializzata, oggi a disposizione, siano di vitale importanza per la diagnosi e la guarigione di un paziente. Ma al tempo stesso è da considerare anche che tutta questa tecnologia ed altri fattori meramente burocratici abbiano “allontanato” dal dialogo medico e paziente. Ad esempio, se il medico intende venire a capo dell’enigma che gli si presenta ogni giorno, deve comunque dare al paziente il tempo sufficiente (e con tutta tranquillità) di parlare; diversamente, se il malato viene inibito o interrotto ripetutamente, potrebbe omettere qualcosa di essenziale. Secondo una prassi logica il medico deve far percepire un interesse sincero per ciò che il paziente ha da comunicargli, perché quando egli comincia a raccontare solitamente fornisce indizi per ipotesi cui il medico non immagina in quel momento. Perciò va da sé che se il medico è capace di entrare in contatto con le emozioni del paziente, può fornire ben più di un sostegno psicologico. Ma non di rado tra medico e paziente si manifesta antipatia, in quanto più i pazienti sono malati e meno i medici provano simpatia per loro, e di questa manifestazione i pazienti se ne accorgono; per contro, e più in generale, i medici tendono a provare simpatia verso le persone… meno malate. Ed è, per certi versi, inconcepibile che alcuni medici provino “avversione” (doverose le virgolette) per i pazienti più gravi mentre ciò non dovrebbe avvenire; probabilmente perché alcuni medici di fronte a queste situazioni provano un senso di fallimento, specie quando si trovano ad affrontare malattie particolarmente resistenti alle migliori terapie, o addirittura quando non sono in grado di fare una diagnosi. Quindi, è di per sé ovvio che il compito principale di un medico è offrire il dialogo: non sarebbe possibile fare una buona medicina senza impostare una buona comunicazione. Il canadese dottor William Osler (1819-1949), eminente patologo, sosteneva: «Se ascolti il paziente quando ti parla, sarà lui stesso a darti la diagnosi». Da qui, oltre alla visita, è più facile l’intuizione clinica anche se per arrivarci il percorso è complesso, un percorso durante il quale il medico può perfezionarsi proprio con la pratica, l’ascolto e l’esperienza. «La cosa più difficile dell’essere un medico – disse un clinico – è che si impara meglio dai propri errori». Probabilmente sono pochissimi i medici che, consapevoli di poter sbagliare una diagnosi o una terapia, tengono un registro dei propri errori, analizzarli di volta in volta specie quando si trovano di fronte a qualche dubbio. Ed è inopinabile che nessuno ha la verità a portata di mano: tutti gli specialisti, anche quelli di provata esperienza, fanno diagnosi a volte sbagliate e prescrivono terapie non adatte (ovviamente in buona fede); in questi casi per errore medico si intende il prescrivere un farmaco in dosi non appropriate al caso, oppure osservare una radiografia all’inverso. Diversi gli errori diagnostici sia per ignoranza in materia che per “leggerezza” o insufficiente valutazione di più parametri, od ancora per questioni cognitive. In merito a ciò taluni medici tendono a preferire l’ipotesi più benigna rispetto a quella più funesta: una tendenza considerata normale che rientra nel cosiddetto “errore affettivo”.
Da qui il suggerimento del medico statunitense Francis Weld Peabody (1881-1927 – nella foto) nel corso di una conferenza nel 1925 presso la Harvard Medical School: «Il segreto della cura del paziente consiste nel prendersi cura del paziente». Lo stesso clinico, noto tra l’altro per le sue ricerche sulla poliomielite e la febbre tifoide, precisava inoltre: «Diventare immuni ai sentimenti significa sminuire il ruolo di guaritore che è proprio del medico, e confinarlo a una sola dimensione del suo lavoro, quella di esperto… Se cancelliamo le emozioni non riusciamo a prenderci veramente cura del paziente: i sentimenti ci aiutano a non rimanere ciechi verso l’anima del paziente, ma rischiano di renderci ciechi nei confronti della sua malattia». Il medico capace di entrare in contatto con le emozioni del paziente, può fornire ben più di un semplice sollievo psicologico. Ma i medici, come qualsiasi altra persona, quando si trovano di fronte all’incertezza rivelano determinate caratteristiche psicologiche. Tendono a stimare in modo eccessivo le proprie capacità: si convincono di avere sempre ragione sulla scorta del fatto che di solito è così. Inoltre, tendono a concentrarsi sui dati positivi anziché su quelli negativi; quelli positivi sono molto più attraenti dal punto di vista emotivo, proprio perché suggeriscono un esito favorevole… Ecco che in questi casi (come in altri) emerge il carattere del medico che può avere un impatto significativo sull’accuratezza delle diagnosi, e questo vale per tutti, anche per quei medici che, come ad esempio i radiologi, non hanno un contatto diretto con il paziente. Tutto sommato, io credo che tutti i medici (o quasi) traggono soddisfazione dalla loro attività, non solo dalla risoluzione di uno o più casi, ma anche se sono riusciti ad instaurare un buon rapporto colloquiale con i pazienti decifrandone il carattere per “facilitarne” una migliore intesa e una più concreta compliance. Queste e altre considerazioni si possono dedurre dalla corposità del libro “Come pensano i dottori” di Jerome Groopman (pagg. 349, Ed. Mondadori, 2008). L’autore, professore di Medicina presso la Harvard Medical School, dirige il Dipartimento di Medicina Sperimentale al Beth Israel Deaconess Medical Center di Boston, ed egli stesso è stato un paziente per lungo tempo. Molte al suo attivo le pubblicazioni, e quella su indicata è pure un contributo per farci comprendere, sia pur indirettamente, che il degrado italiano è spesso dovuto all’assenza di meritocrazia e in taluni casi di deontologia. I casi da lui citati nell’opera, sia dei colleghi che dei loro pazienti trattati, lasciano un segno non solo per un confronto ma anche per alcune riflessioni.
