“Il lupo della steppa” di H.Hesse
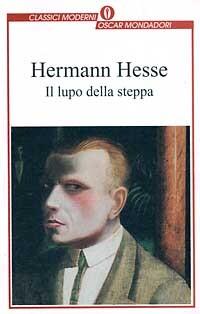
Hesse
di Davide Morelli
Ho letto questo romanzo di Hesse da ragazzo e allora non avevo nessuna comprensione empatica nei confronti della crisi interiore né della condizione esistenziale del protagonista Harry, che in definitiva era quello dello stesso autore, essendo in parte autobiografico. Oggi mi identifico in Harry. Mi sento anche io un lupo della steppa, forse perché sono anche io come il protagonista un uomo sulla cinquantina. Harry vive in una fase di transizione tra due epoche. Questo romanzo è del 1927. Harry è prima di tutto un inetto non perché non vuole fare ma perché non sa cosa vuole fare. Di fronte a lui l’angoscia della scelta degli esistenzialisti. È come un asino di Buridano, combattuto tra natura e spirito, e perciò inerme, fino a quando nella sua vita sempre uguale non irrompe Erminia. Se Beckett aveva scelto il teatro perché “spazio definito”, nel finale di questo romanzo invece lo spazio e il tempo diventano indefiniti al massimo livello. Potremmo affermare che questo romanzo, sotto forma di memorie, è la storia di un arricchimento esperenziale, ma poi bisogna anche ricordare che, come scriveva Schopenhauer, l’uomo può fare ciò che vuole, ma non sa volere ciò che vuole. Inizialmente c’è la dicotomia tra uomo e lupo, tra la dimensione sociale e quella selvaggia, animalesca. È l’antico manicheismo tra bene e male, ovvero tra carne e spirito. Ma in questo romanzo c’è un intreccio inestricabile tra natura e cultura, e la complessità si può capire anche dalla dissertazione presente nel romanzo. Harry è da solo, vive in una stanza d’affitto, è sull’orlo del suicidio. È isolato per questioni ideologiche: è pacifista e contro il nazionalismo. È isolato e solo perché intellettuale non riconosciuto a livello socioculturale. È isolato e solo perché di estrazione borghese e di formazione antiborghese. È un uomo che vive la duplicità, il dissidio, la lacerazione da tutti i punti di vista. È un uomo che hegelianamente contrappone l’antitesi alla tesi, senza mai giungere alla sintesi, alla riappropriazione di sé, al ritorno in sé. Ad esempio non può rinnegare totalmente la sua borghesia perché sarebbe sradicato, sarebbe un albero senza radici, e ciò vorrebbe dire rinnegare anche sé stesso. E poi quale sarebbe l’alternativa? Rinchiudersi in una torre eburnea? Fare come Thoreau e andare a vivere nei boschi? Erminia, sua donna fatale, gli insegna a ballare il fox trot, l’aiuta a entrare nella mondanità, lo fa incontrare una donna con cui si congiungerà carnalmente. Harry non riesce a purificare il proprio ego dalle sue pulsioni sessuali, dagli impulsi del basso ventre: resta un uomo del suo tempo, lo stesso uomo medio sensuale dell’Ulisse di Joyce (vi ricordate quando Leopold Bloom si masturba guardando una ragazza chiacchierare con le amiche?). C’è un fil rouge che lega questo romanzo a “La nausea” di Sartre e a “La noia” di Moravia: il malessere esistenziale, il disagio interiore, il senso di scacco matto che la realtà dà ai protagonisti. Hesse è influenzato dalla psicanalisi e dall’esistenzialismo. Queste matrici culturali gli permettono di scrivere un romanzo che in parte è di formazione, ma in parte è una catabasi dell’animo: un processo di individuazione non compiuto definitivamente e con un tragico epilogo allucinatorio e onirico. Hesse ci rivela che l’uomo è tutto in potenza: angelo e demonio, santo e assassino, bestia e Dio. Erminia non è Beatrice che guida spiritualmente Dante, né Euridice, che Orfeo cerca di salvare dagli inferi con il suo canto. Harry non salva né è salvato da nessuna. Il suo inferno non è ultraterreno ma terreno, quotidiano. Perché Harry non vince il suo inferno? Perché non riesce nell’ epoché, non riesce a mettere tra parentesi l’io, né il mondo, ma solo la sua coscienza e con essa la sua morale, la sua etica. Harry scoprirà non di avere solo due lati interiori, la natura e lo spirito, ma molte subpersonalità (la falsa unità della coscienza, la moltiplicazione degli io), ovvero si renderà conto di essere uno, nessuno e centomila. Ma Hesse aveva previsto già che con l’avvento del nazismo il lupo della steppa sarebbe diventato il lupo del deserto cieco, barbaro e nichilista. Se il teatro dell’assurdo di Beckett e Ionesco scarnificherà il linguaggio (ne “La cantatrice calva” l’unica metafora decente è quella del fuoco del pompiere, quando invece Aristotele aveva scritto che la metafora è necessaria nell’arte), denunciando l’illogicità e l’insensatezza dell’esistenza con le conversazioni quotidiane, se Heidegger aveva visto nella chiacchiera impersonale l’inautenticità della vita, Hesse intuisce perfettamente in questo romanzo l’assurdità della vita nella casualità e nel gioco talvolta crudele degli incontri. Ma per Hesse la vita in sé e per sé non ha senso, ma siamo noi che dobbiamo darle un senso, come sostenne lo stesso scrittore. E allora cosa può salvare i lupi della steppa? “Imparare a ridere” come dice Mozart a Harry. E poi? Hesse dichiarò che nella vita bisogna avere un credo. E quale può essere? Si può credere negli immortali del “teatrino magico”, nell’arte dell’ozio, nella fede in Dio, nell’arte stessa. In fondo Hesse dichiarò che aveva posto come fondamento di ogni sua opera il credo, declinandolo in modo diversi.